
Vittima di un assassinio spettacolarmente brutale per mano di una folla di uomini, la fama di Ipazia è assicurata dal martirio che subì.
E ora con Agora si è avuto il suo primo ritratto cinematografico, dopo che, in questi ultimi tre secoli, in letteratura, pittura, teatro e filosofia si è adottata la sua figura storica per esprimere una serie di contenuti e di implicazioni in una misura tale che non è facile ricostruire e certamente non è possibile farlo nei limiti di questo mio contributo.
La violenta natura del crimine, una sorta di esecuzione rituale (o meglio contro-rituale), come pure le sue sottili implicazioni politiche e religiose esortano al suo ricordo sia per chi ne ama la figura sia per chi ancora l’avversa oppure minimizza la sua fine o, comunque, con le consuete maniere curiali e sofistiche, confuta, rispetto a una presunta realtà storica, i modi in cui è stata sottratta all’oblio e a una comoda damnatio memoriae. Perché così, a dispetto di questi ultimi, vanno le cose a questo mondo. Il tempo è anche galantuomo perché viene un momento in cui restituisce giustizia e verità.
Nel bel mezzo del carsico inabissarsi della tradizione pitagorico-platonica si innalza, nel IV-V secolo, la Scuola di Alessandria, quasi come una istituzione scampata, sfuggita alla fatalità storica del nuovo che avanza, inesorabile. Come tale destinata a morire e avente i suoi martiri che, come la speciale figura femminile che la rappresenta, solo da non molto ha raggiunto la notorietà, ma non ancora la trascendenza che merita. Pensate che solo ottant’anni fa una filosofa spagnola, María Zambrano, in un suo bel libro sull’intelligenza dell’amore, poteva dire: «Ipazia mostra il martirio più terribile, infertole dai seguaci di una Religione che crebbe grazie a esso. La sua luce fu offuscata da quella dei martiri avversari. In una specie di martirio che non è stato segnalato perché il mondo, avaro nel concedere gloria, ha ritenuto sufficiente segnalare e conservare solo quello dei martiri trionfanti, dimenticando gli altri».
Ipazia, grazie al medium cinematografico (con i suoi innegabili limiti, ma anche con la sua capacità di raggiungere un pubblico più vasto) e ai diversi libri che hanno indagato a fondo le testimonianze antiche e la sua ricezione, oggi è nota a molti e viene valorizzata non più come un esempio decontestualizzato di una filosofa, matematica e astronoma donna, ma come personaggio storico degno di uno speciale interesse proprio per le cause del suo assassinio.
È opportuno rammentare che a inaugurare il moderno mito di Ipazia fu John Toland, un Massone, anzi un proto-Massone, dato che è attestata la sua affiliazione a una Loggia dell’Aja, “I Cavalieri del Giubilo”, già nel 1710. Esponente della corrente dei freethinkers – i liberi pensatori o libertini anticipatori degli illuministi razionalisti – c’è un certo imbarazzo sull’importante ruolo che ha avuto Toland nella nascita della Massoneria, tanto che il suo nome, a causa delle sue speculazioni teologiche e panteistiche reputate “irreligiose” o “eterodosse”, è di solito omesso nelle opere storiografiche di massoni sulle origini della Libera Muratoria moderna.
Toland nel 1720 pubblicò un saggio dal titolo Ipazia, o la storia di una Dama molto bella, molto virtuosa, molto istruita e perfetta sotto ogni riguardo, che fu fatta a pezzi dal Clero di Alessandria per compiacere l’orgoglio, l’emulazione e la crudeltà del suo Arcivescovo, comunemente ma immeritatamente denominato San Cirillo. Diversamente dal lungo titolo è un opuscolo di poco più di una trentina di pagine, suddiviso in ventidue brevi capitoli, in cui, utilizzando le fonti antiche allora disponibili, si ricostruisce con precisione la vicenda. Toland legge nell’episodio dell’assassinio della donna-filosofo, la storia dell’eterno antagonismo tra l’ignoranza e il sapere, tra la scienza e la superstizione, tra la ragione e il fanatismo religioso. Considerato come un pamphlet anticristiano, si meritò subito, l’anno dopo, una replica dal controversialista clericale Thomas Lewis. Il libello con il non meno provocatorio titolo La Storia di Ipazia, l’impudentissima maestra della Scuola di Alessandria: assassinata e fatta a pezzi dalla popolazione, in difesa di San Cirillo e del clero alessandrino Dalle calunnie del signor Toland.
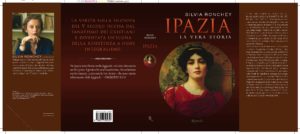
La posizione di Toland, in realtà, è quella di una difesa del cristianesimo “naturale”, delle origini, quello dell’autentico insegnamento evangelico contro la decadenza della Chiesa in quanto istituzione. Scrive infatti: «No no! non erano cristiani quelli che uccisero Ipazia, né gli uomini del clero cristiano devono ora essere attaccati al posto di coloro che furono davvero protagonisti di quell’omicidio, ma solo quelli che assomigliano a cristiani; che hanno sostituito tradizioni precarie, finzioni scolastiche e un dominio usurpato, alla salutare istituzione del sacro Gesù».
Diversamente il lavoro di Toland fu accolto con entusiasmo negli ambienti latomici che pensavano di abbattere definitivamente le barriere che la religione imponeva alla libertà di pensiero.
Il Fratello Voltaire nel suo Un importante esame di Lord Bolingbroke o la tomba del fanatismo (1736), evoca San Cirillo e il clero di Alessandria e presenta la morte di Ipazia come un assassinio perpetrato da «i mastini tonsurati di Cirillo, seguito da una schiera di fanatici». Voltaire se ne occupa di nuovo nel suo Dizionario filosofico (1764), dove, concludendo la storia di Ipazia, scrive col suo polemico sarcasmo e la sua ironica galanteria: «Mi limito a notare che san Cirillo era un uomo; e un uomo di partito. Che si è forse lasciato trasportare troppo dallo zelo. Che quando si spogliano nude le belle signore non è per massacrarle. Che san Cirillo ha senza dubbio chiesto perdono a Dio di quest’azione abominevole. E che prego il Padre di Misericordia di avere pietà della sua anima». Anche nel successivo Della pace perpetua (1769) paragona il vescovo di Tolemaide Sinesio, discepolo di Ipazia, e Cirillo che porta il nome di santo, suggerendone il contrasto, e dice di Sinesio, il quale non solo non rinunciò a sua moglie, ma non credeva nella resurrezione dei corpi né che l’anima si producesse dopo il corpo, che: «I vescovi insistettero: lo si battezzò, fu fatto diacono, sacerdote, vescovo; conciliò la sua filosofia col ministero; è uno dei fatti più accertati della storia ecclesiastica. Ecco dunque un platonico, un teista, un nemico dei dogmi cristiani, vescovo con l’approvazione dei suoi colleghi, che fu il migliore dei vescovi; mentre Ipazia è piamente assassinata nella chiesa, per ordine o almeno con la connivenza di un vescovo di Alessandria decorato col nome di santo. Lettore, rifletti e giudica; e voi, vescovi, cercate di imitare Sinesio».
Ma chi più contribuì a riscattare dalla dimenticanza Ipazia fu il Fratello Edward Gibbon. Gibbon, nella sua importante Storia del declino e della caduta dell’Impero romano (1788), ne utilizzò la vita e la morte per illustrare la differenza tra il mondo antico e quello che si stava sostituendo ad esso – la ragione e la tradizione spirituale nel caso di Ipazia contro la barbarie e il dogmatismo, nel caso di Cirillo e il cristianesimo. L’assassino di Ipazia non era solo l’ultimo atto della lotta contro la civiltà greco-romana, ma la morte della sapienza in Occidente. È tale l’importanza del suo passo sulla matematica alessandrina e fu così cruciale nel recupero della sua memoria, che, nonostante le diverse imprecisioni storiche, vale la pena ricordarlo:
«S. Cirillo volle ben tosto, o accettò il sagrifizio d’una vergine che professava la religione dei Greci, e avea legami d’amicizia con Oreste. Ipazia, figlia del matematico Teone era dotta nelle scienze coltivate dal padre; i suoi bei commentari hanno rischiarata la geometria

d’Apollonio e di Diofante, ed ella pubblicamente in Atene ed in Alessandria insegnava la filosofia di Platone e d’Aristotele. Congiungendo a tutta la freschezza dell’avvenenza, la maturità della sapienza, era ritrosa alle preghiere degli amanti, e si contentava d’istruire i suoi discepoli. Era corteggiata continuamente dalle persone per grado e per merito le più illustri, e S. Cirillo scorgeva con occhio di gelosia il pomposo codazzo di schiavi e di cavalli che attorniava la porta dell’Accademia di quella giovine. Si divulgò tra i Cristiani la voce, che il solo ostacolo alla riconciliazione del Prefetto e dell’Arcivescovo fosse la figlia di Teone, e quest’ostacolo fu ben presto levato. In uno dei santi giorni di quaresima, Ipazia, tornando a casa, fu svelta a forza dal suo carro, spogliata degli abiti, trascinata alla chiesa, e trucidata da Pietro il Lettore, e da una turba di spietati fanatici; fu tagliuzzato il suo corpo colle scaglie di ostrica, e abbandonate alle fiamme le sue membra ancor palpitanti. Con denari sparsi a tempo fu impedita l’informazione giuridica incominciata su questo delitto; ma l’assassinio d’Ipazia ha posto una macchia indelebile al carattere ed alla religione di S. Cirillo Alessandrino».
Consentitemi di dire che di questa macchia indelebile (come, del resto, di altre) non ci si è mai scusati. Anzi, nel tempo – e anche in quello più recente –, la si è di più insozzata contornandola di nuovi aloni. Non solo Cirillo, già santo sia in Oriente che in Occidente, fu proclamato nel 1882 da papa Leone XIII dottore della Chiesa, a ulteriore premio delle sue imprese, col titolo di Doctor incarnationis. Del resto Leone XIII era lo stesso papa che un anno prima dell’inaugurazione del monumento a Giordano Bruno in Campo de’ Fiori, in un allocuzione aveva confermato in pieno la legittimità della condanna e del rogo per un uomo «doppiamente apostata, convinto eretico, ribelle fino alla morte all’autorità della Chiesa» e che peraltro «non possedeva un sapere scientifico rilevante». Come ha ricordato Silvia Ronchey, citando Umberto Eco, era «un papa ossessionato dal nuovo paganesimo rappresentato dalla massoneria e dai liberali mangiapreti che dominavano nella Roma dei suoi tempi». Ma a Cirillo, solo qualche anno fa, è stato dedicato da Benedetto XVI un lungo discorso elogiativo «senza spendere due righe», come è stato osservato, «per assolverlo da quell’ombra che la storia ha fatto pesare su di lui». Benedetto XVI, in una delle sue non uniche esternazioni imbarazzanti, ci ha detto che «seguendo le tracce dei Padri della Chiesa, incontriamo una grande figura: san Cirillo di Alessandria […] fu più tardi definito “custode dell’esattezza” – da intendersi come custode della vera fede – e addirittura “sigillo dei Padri” […] resse con mano ferma e grande prestigio la Diocesi alessandrina […] che governò con grande energia per trentadue anni».
Sarebbe certo deluso, anzi allibito, nel vedere assurgere quest’uomo di grande energia a tali picchi di celebrità, l’ignoto contemporaneo che in occasione della sua morte, nel 444, pronunciò questo necrologio: «Finalmente quell’essere odioso è morto. La sua dipartita rallegrerà i vivi, ma il suo arrivo tra loro disturberà i morti, che non vorranno aver commercio con lui e cercheranno di tornare fra noi. Perciò posate una pietra pesantissima sulla sua tomba, perché non corriamo il rischio di vedercelo ricomparire davanti neppure come fantasma».
Aveva dunque ragione Toland nel dire che è «una beffa insopportabile nei confronti di Dio e degli uomini riverire una persona così ambiziosa, così turbolenta, così perfida e così crudele» e che i titoli vengono conferiti «non di rado … in modo infelice … in primo luogo a quegli uomini che hanno promosso la grandeur della Chiesa».
Dalla catechesi di papa Ratzinger apprendiamo che il merito principale di Cirillo è stata la sua lotta contro Nestorio, patriarca di Costantinopoli che definiva Maria «Madre di Cristo» (Christotókos), con la sua proclamazione della Madonna come «Madre di Dio» (Theotókos). Come già acutamente osservava Toland nel 1720: «… dottrine e distinzioni … mai insegnate da Cristo e dai suoi Apostoli». Lo ribadiva, a proposito di Cirillo e Nestorio, ancora Voltaire nel suo Dizionario filosofico: «Prendi nota, lettore, che il Vangelo non ha mai detto una parola […] dell’onore toccato a Maria d’esser madre di Dio, né di tutte le altre questioni che hanno fatto riunire tanti concili infallibili». Lo riafferma Luciano Canfora osservando, con un’amarezza pari all’ironia, come il «mandante morale della uccisione, plateale e sadicamente feroce, di una donna, che è anche una notevole scienziata, colpevole di non voler essere cristiana ma assertrice della filosofia e della scienza greca» abbia avuto come esito nella Chiesa che «quel vescovo, così politico e così spregiudicato (per non dir peggio) viene – post mortem – proclamato santo e “dottore della chiesa” (per aver escogitato lo stravagante dogma che proclamò Maria “madre di Dio”, θεοτόκος, in quanto madre di Gesù, cioè del “figlio”)».
A fronte dell’assordante silenzio ecclesiale su Cirillo e la sua vittima sacrificale, soprattutto da parte di chi fa oggi della sacralità della vita umana un principio non negoziabile da tutelare dal livello embrionale fino allo stato vegetale, altri massoni arricchirono il mito di Ipazia. Potremmo fare, in questa lignée libero-muratoria all’insegna di Ipazia, i nomi certi di Christian Wolff, di Christoph Martin Wieland, di Vincenzo Monti, forse quello di Augusto Agabiti, fino a quello di Hugo Pratt. Sarebbe però, in questa sede, un inutile e tedioso sfoggio di erudizione fine a se stessa. Anche perché bisogna dire che, grazie agli studi che si sono succeduti, è stato riunito tutto ciò che si può sapere oggi su questa donna straordinaria, sul suo assassinio e su ciò che di lei è stato detto. C’è quindi la possibilità di soddisfare sull’argomento ogni curiosità.
Vorrei invece abusare della vostra pazienza per toccare alcune altre questioni che a me paiono di cruciale importanza.
La prima questione riguarda due domande fondamentali che sono chi uccise Ipazia e perché? Alla prima delle questioni la risposta c’è, anche se c’è ancora qualcuno che la mette in discussione. Autori del terribile linciaggio furono i parabalani, una sorta di milizia privata paramilitare impiegata dal patriarca per difendere i propri interessi al tempo in cui i conflitti teologici erano particolarmente violenti. Questi chierici, reclutati tra la popolazione di più infimo rango, avevano alcuni compiti infermieristici di assistenza ai malati, quello di barellieri e di bruciare i corpi dei cadaveri, in particolare dei lebbrosi. Ma il compito principale di questa truppa di circa 500 uomini era quello di seminare il terrore e mantenere l’ordine religioso nella città di Alessandria.
Sul perché è stata uccisa, se ci limitiamo a leggere le opere degli storici, la risposta sembra più difficile, anche se in cuor nostro, in quanto Massoni, la risposta l’abbiamo e ve la dirò.

Sulle ragioni, nei diversi studi che si sono moltiplicati, a dispetto della scarsità e brevità delle fonti che riferiscono l’incidente e il suo contesto, ogni storico, scrittore e scienziato inclina a diverse possibilità. Ed è tale la varietà di interpretazioni, tendente a rafforzare la particolare inclinazione dell’interprete, che anch’io faccio fatica a riassumerle.
Nel 361 ad Alessandria era stato assalito il Tempio di Mitra. Nel 391 il patriarca Teofilo, predecessore e zio di Cirillo, scoprì e distrusse il Tempio di Dioniso, il cui culto misterico era celebrato in grande segreto, e incitò i cristiani ad abbattere il Serapeo, il Tempio di Serapide, dove era contenuta l’ultima importante biblioteca della civiltà classica. Cirillo divenuto patriarca di Alessandria nel 412 avviò un sistematico programma di oppressione ed eliminazione contro le altre religioni, in primo luogo contro la fiorente comunità ebraica di Alessandria (si parla dell’espulsione di circa centomila persone dalla città con confisca dei loro beni e distruzione delle sinagoghe), contro i politeisti pagani e contro gli eretici cristiani (novaziani – anche di essi confiscò i beni – e nestoriani contro cui condusse un’aspra battaglia).
Ipazia era considerata da Cirillo una minaccia al potere della Chiesa ad Alessandria. Era molto amica del prefetto dell’Egitto Oreste che aveva l’incarico di amministrare la città e la cui influenza rappresentava la sola forza equilibratrice contro il patriarca Cirillo, tendente ad usurpare la condizione e l’autorità della magistratura civile. Viceversa Oreste era in pessimi rapporti con Cirillo ed era stato più volte attaccato dai monaci. Sebbene fosse considerata un’ellena, ossia una pagana, sono noti i suoi stretti legami con molti cristiani. Uno dei suoi discepoli, il fedele Sinesio, come già sappiamo, divenne un vescovo. Lo stesso Oreste era un battezzato, altri cristiani suoi amici erano potenti uomini di corte e nobili. Tutti erano considerati una minaccia per Cirillo. La filosofia di Ipazia, il suo insegnamento, i consigli che dispensava potevano dunque essere considerati un pericolo per l’ortodossia cristiana e poteva essere sospettata di avere connessioni con l’uno o l’altro gruppo perseguitato.
Rispetto al semplice schema dello scontro tra cristianesimo e paganesimo alcuni storici preferiscono dar spazio a un piano assai più complesso e che dà conto di una lotta che, pur combattendosi nelle forme tipiche della disputa religiosa, è innanzitutto funzionale al primato politico e sociale, al potere. In questo senso Ipazia, per i sostenitori di Cirillo e del potere temporale della Chiesa, era l’ultimo degli idoli da abbattere. Ipazia fu fatta fuori come una pedina nelle rappresaglie di questa partita a scacchi tra potere civile e potere religioso. Fu un assassinio politico.
E ancora. Anche se la maggior parte dei resoconti del tempo pongono maggior enfasi sull’impatto sociale della sua vita piuttosto che sui suoi contributi alla scienza e alla matematica, non va dimenticato che, nella campagna propagandistica, il suo insegnamento era presentato come magia. Suo padre come lei praticavano l’astrologia; si dedicava agli strumenti musicali; la si ricorda, poi, come inventrice di un areometro, di un idrometro, di un apparecchio per la distillazione e di un astrolabio. È difficile che l’accusa di stregoneria fosse creduta da chi diffuse la diceria, ma poteva essere accettata dai parabolani, notoriamente incolti e superstiziosi. Giovanni di Nikiu considera il linciaggio della donna filosofo una meritata punizione, perché Ipazia seduceva e abbindolava Oreste e gli altri suoi discepoli con la magia e i suoi inganni satanici. In questo senso Ipazia è la prima strega bruciata dai cristiani. Fu uccisa perché era una scienziata.
C’è, pertanto e infine, il fatto che era una donna e questo la rendeva ancor più vulnerabile.
Consentitemi di tornare al capostipite degli studi ipaziani: al nostro John Toland. Il suo opuscolo non contiene solo un attacco alle gerarchie ecclesiastiche che hanno tradito lo spirito originario di Gesù Cristo, ma vi è anche inserito, già a quel tempo, un elemento profondamente pro-femminista. Vi si afferma, fin dalle prime righe, che la sua «narrazione canterà per sempre la gloria del suo sesso, e la miseria del nostro» e che l’assassinio sacrilego perpetrato contro l’incarnazione della bellezza, dell’innocenza e della conoscenza, segna in modo indelebile la parte maschile del genere umano.
Io ritengo che uno dei motivi per cui il Fratello Toland non è ricordato nelle opere di storiografia massonica sia anche questa sua venerazione per il genere femminile che lo rende eccentrico o, per meglio dire utilizzando un’espressione latomica, irregolare. Toland in un altro suo precedente scritto – nella prefazione alle Letters to Serena (1704) – si domandava se «l’esclusione delle donne dalla cultura sia effetto di un’abitudine inveterata o derivi piuttosto da un progetto esplicito» e, data per dimostrata l’eguaglianza intellettuale in entrambi i sessi, dichiarava – in un’epoca in cui le donne diversamente dagli uomini non avevano diritti – che se esse avessero avuto gli stessi vantaggi ed opportunità di un uomo libero sarebbero state «capaci di ogni genere di miglioramento».
Ciò che si vuol dire è che, grazie a Toland, la figura di Ipazia come simbolo della sapienza femminile si è frequentemente prestata alla causa del proto-femminismo e del femminismo. Sarebbe insieme simbolo della distruzione del genio femminile del tradizionale mondo classico greco-romano ed emblema dell’avvento della società patriarcale e misogina del potere ecclesiale e della riduzione al silenzio della voce femminile per molti secoli a venire e da cui, credetemi, persino, la nostra Istituzione è contaminata.
D’altra parte il femminicidio di Ipazia – come diremmo oggi – diventa un segno di contraddizione nell’antagonismo tra i sessi. Così come ogni donna può immedesimarsi in lei, ogni uomo identificandosi con i suoi assassini ne è sempre il potenziale persecutore. Aveva dunque ragione l’attivista e intellettuale britannica Dora Russell, nel pamphlet intitolato Ipazia o donna e conoscenza, ad invitare gli uomini e le donne ad «allentare la presa che le passioni più vili hanno sulla nostra politica e sulla nostra morale […] Gli uomini e le donne […] sono fuochi che si intrecciano nella conoscenza, torrenti che balzano in cascate di estasi condivisa. Non c’è niente nella vita che possa paragonarsi a questo unirsi di menti e corpi di uomini e donne che hanno lasciato da parte ostilità e paura e che cercano nell’amore la più piena comprensione di se stessi e dell’universo».
Trovo dunque assai grazioso che il suo più celebre marito, il filosofo Bertrand Russell, abbia scritto di Cirillo, esempio di quella controparte maschile che ha privato per secoli le donne sia della cittadinanza che dell’educazione, talora togliendo loro anche la vita o spesso qualcosa che le somigliasse, che «il suo principale titolo di notorietà è il linciaggio di Ipazia, una donna di gran riguardo che, in un’epoca bigotta, aderiva alla filosofia neoplatonica e dedicava le sue facoltà intellettuali alla matematica […] Dopo di che Alessandria non fu più turbata dai filosofi».
Nel corso di questo contributo da contenere in limiti accettabili, non è possibile analizzare il ruolo del femminile nel divino e nel sacro: si pensi alla Grande Madre in Occidente e alla Shakti in Oriente, alla Pistis Sophia gnostica, alla Beatrice di Dante e alle donne dei Fedeli d’Amore, all’Amata del sufismo … sono tutte immagini esoteriche declinate al femminile.
Ma, pur non essendoci la possibilità in questa sede di occuparci dell’archetipo tradizionale della Sapienza muliebre, quantomeno il fatto che Sinesio, quando era già vescovo, continuasse a chiamar Ipazia «madre, sorella e maestra» (meter kai adelphè kai didáskale), attira la nostra attenzione sull’iniziazione femminile, ossia sulla trasmissione di un’influenza spirituale sia in senso attivo che passivo.

Anche in questo caso ci dobbiamo ridurre a constatare l’enormità di una presunta, inesistente e mai esistita iniziazione solare. Sul piano concreto e storico, ci limitiamo a constatare quante donne in Occidente, oltre a e prima di Ipazia, hanno contribuito a erigere e mantenere viva la Tradizione: la sacerdotessa delfica Temistoclea iniziatrice di Pitagora, Teano e la settantina di Pitagoriche menzionate da Giamblico, Aspasia e Diotima … Le forme del mondo fenomenico che nascono sotto una determinata forma, mutano e periscono, sono solo prototipi o copie dell’Idea del Bello o dell’Essere. Come è dunque pensabile che l’iniziazione, che è la seconda nascita o realizzazione del vero sé, possa essere un fatto di identità sessuale?
Ipazia, eroina pagana massacrata dai cristiani, o eroina degli ariani massacrata dagli ortodossi, o ancora un’eroina dei civili cristiani di Costantinopoli massacrata dagli intemperanti cristiani d’Alessandria; e più di recente eroina anticlericale, vittima della gerarchia ecclesiale; eroina protestante, vittima della chiesa cattolica; eroina del romanticismo ellenizzante, vittima dell’abbandono da parte dell’Occidente della civiltà greco-romana; eroina del positivismo, vittima dell’oppressione della religione sulla scienza; e, in ultimo, eroina del femminismo, vittima della misoginia cristiana. In breve, vittima di qualsiasi fondamentalismo religioso, Galileo in gonnella, martire del libero pensiero, bandiera della laicità, proto-femminista … Permettetemi di non contrappormi a nessuna di queste tesi su Ipazia, ma di essere aperto a tutte le interpretazioni, a tutte le molteplici sfaccettature del recupero d’Ipazia, salvo che non siano manipolazioni. Ognuna di esse svolge il suo ruolo, perché c’è posto per tutti i punti di vista. Tutte le distinzioni possono essere risolte, armonizzate e trascese se consideriamo Ipazia un simbolo. Proprio perché il simbolo racchiude in sé molteplici significati, talvolta apparentemente diversi tra loro ma sempre intimamente correlati, e, col riunificare valori separati, ricrea un ordine ed un’armonia superiore, una costante assoluta. Possiamo ancora considerare che tutte le chiavi interpretative, anche ideologiche, descrivono sempre l’irrompere del caos, delle tenebre, dell’ignoranza e della discordia contro l’ordine, la luce, la conoscenza e l’armonia o il ciclo inevitabile del declino. In questo senso su Ipazia è stata costruita un’intelaiatura pronta a farne un archetipo.
E adesso posso rispondere perché Ipazia è stata uccisa. Permettetemi, a questo punto, parafrasando un celebre principio metodologico chiamato il rasoio di Occam e che recita «a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire», di utilizzare il rasoio di Hiram, la spiegazione massonica: Ipazia è stata uccisa per ignoranza, fanatismo e ambizione.
Indipendentemente da tutte le Ipazie moderne e i diversi modi in cui è stata acconciata, come spiega la Ronchey: «… su un punto non si può non essere concordi: a qualunque cosa Ipazia sia somigliata di più, a una studiosa o a una sacerdotessa, a una composta insegnante o a un’aristocratica eccentrica e trasgressiva, che sia stata giovane o no, che abbia fatto davvero innamorare i suoi allievi, che abbia o no – non è escluso – scoperto qualcosa di nuovo; che l’insegnamento iniziatico da lei impartito con tanto successo all’inquieta aristocrazia ellenica offrisse o no già la rivelazione che a un livello alto la teologia platonica inglobava quella cristiana e che gli improbabili dogmi di quest’ultima andavano tollerati, praticando l’arte platonica della “nobile bugia”, perché utili al popolo quanto ogni antica superstizione pagana; che sia stata risoluta nello sbarrare il passo all’ingerenza della chiesa nello stato, e troppo ingombrante nello sfidare la strategia di Cirillo con la sua parrhesia, o che la morte sia stata solo un incidente dovuto al subitaneo isterismo di un influente prelato cristiano ottenebrato dall’emulazione e dall’ambizione, oltreché al momentaneo disorientamento di un prefetto Augustale romano messo in difficoltà da un vuoto di potere imperiale; in ogni caso, ogni volta che nella storia si ripropone, e si ripropone spesso, il conflitto tra un Cirillo e un’Ipazia, una cosa è certa: siamo e saremo sempre dalla parte di Ipazia».
Filosofare è un mestiere pericoloso. Cercare la luce della sapienza e ripromettersi di diffonderla è sempre un rischio.
Tutte le fonti antiche attribuiscono ad Ipazia la convinzione che il nutrimento della filosofia dovesse essere impartito non solo nella propria affollatissima scuola, non solo presso i potenti, ma anche nelle piazze e fra la gente, riconoscendo quindi un ruolo morale, civile e sociale alla filosofia.
Erano molti coloro che volevano ascoltare la parrhesia di Ipazia. È questo un termine che ritroviamo nelle fonti antiche e che viene ripetuto dalla Ronchey nella citazione pocanzi fatta. Ed è un termine difficilmente traducibile nella nostra lingua, ma che di solito viene tradotto come il parlar franco, la sincerità, la libertà di parola. Parrhesia è l’attività di chi dice la Verità, insofferente di ogni presupposto dogmatico, che tutto interroga e tutto problematizza. Ha una duplice significato: filosofico-morale e filosofico-politico. C’è una parrhesia politica e sociale che è il coraggio di dire la verità a proposito del bene della Città a dispetto di qualunque pericolo e rischio, ma prima deve essere preceduta da una parrhesia individuale che mostra che per aiutare gli altri a vivere meglio e per dare utili consigli al governo della Città è necessario prima di tutto essere in grado di governare se stessi. Occorre dire la verità, prima ancora che al prossimo, a se stessi. L’esercizio del potere attraverso la parola o, meglio, attraverso la verità, si dimostra non solo con la parola ma anche con il proprio modo di vivere. In altri termini, come mostra Ipazia, si esercita il magistero solo dopo aver ottenuto la maestranza di se stessi.

La morte di Ipazia, al pari di quella di Socrate, incarna l’esilio della parrhesia. Teniamone quindi viva la memoria e rinnoviamole la nostra gratitudine come oppositrice, con il suo modo di essere e con i suoi pensieri e discorsi, alla barbarie di chi ritiene la propria l’unica verità. Ma facciamolo concretamente, riportando tra noi la parrhesia, virtù, come più o meno è stato detto, apparsa nel V secolo avanti l’era volgare e di cui si sono perse le tracce nel V secolo dell’era volgare, e che è una scelta di vita che coincide con ciò che è veramente la vita reale.
Mi accade sempre più spesso di sentire, con un certo sconforto, che vi è una Massoneria di tradizione esoterico-iniziatica che vive parallela a un’altra Massoneria dagli ideali di natura illuministica. Sarebbero queste le due anime che convivono nella Libera Muratoria: la «corrente calda» esoterica e la «corrente fredda» razionalista.
C’è chi pensa che le scelta esoterica significhi allontanarsi dal mondo, confondendo una sua personale inclinazione, peraltro del tutto legittima, con la nozione di esoterismo, che ci affida, invece, il compito come secondi demiurghi di portare l’Intelligibile nel sensibile e che ci vuole operai che preparano i mattoni con cui più tardi noi stessi o altri più felici architetti potranno elevare un più bello e duraturo Tempio dell’Umanità sul modello di quello cosmico.
Ma il razionalismo che nega ogni principio di ordine superiore o demiurgico e si richiama alla sola ragione razionale e che pensa di lavorare al Bene e al Progresso dell’Umanità, indica spesso il fare e non anche il come essere. Numerosi sono quelli che si immergono interamente nella preparazione del cambiamento sociale; rari, rarissimi quelli che, per realizzarlo, se ne vogliono prima rendere degni.
Ipazia rappresenta quella Tradizione ininterrotta di filosofi – tra i non pochi esempi possibili pensiamo a Pitagora, Socrate, Platone – che non hanno mai rinunciato ad agire sulla città, a trasformare la società, a rendere servizio ai propri concittadini, ad agire secondo giustizia. Che hanno sempre saputo, in altri termini, che la vita filosofica comporta un impegno comunitario (il platonico rientro nella caverna). Ma che hanno sempre avuto altrettanto chiaro che questo impegno esige preliminarmente un duro e intenso lavoro su se stessi. Comporta togliere, raschiare, lisciare, ripulire la nostra pietra, levare da essa il superfluo, raddrizzare ciò che è obliquo, purificare ciò che è fosco e renderlo brillante.

Il messaggio di Ipazia è, dunque, chiaro: in primo luogo realizzazione di ciò che realmente si è, in secondo luogo una continua pratica spirituale da soli o in compagnia di persone – non importa se uomini o donne – che desiderano ugualmente perfezionarsi e, conseguentemente, la tensione alla costruzione del mondo sensibile in cui si vive sulla base del modello cosmico contemplato o dell’ordine universale.
Gemma Beretta, peraltro una studiosa e ricercatrice femminista nel suo libro su Ipazia, riflettendo su un verso di un epigramma dedicato ad Ipazia del contemporanea poeta alessandrino Pallada, che recita «verso il cielo è rivolto ogni tuo atto», sostiene che in esso si condensa tutto il senso dell’attività di Ipazia, ad indicare da un lato l’amore per l’astronomia, dall’altro la tensione filosofica. Ispirandosi a quanto dice il fedele discepolo Sinesio in suo testo, così prosegue la Beretta: «Quando tracciava una nuova mappa del cielo, Ipazia stava indicando una traiettoria nuova – e insieme antichissima – per mezzo della quale gli uomini e le donne del suo tempo potessero imparare ad orientarsi sulla terra e dalla terra al cielo e dal cielo alla terra senza soluzione di continuità e senza bisogno della mediazione del potere ecclesiastico […]. Ipazia insegnava ad entrare dentro di sé (l’intelletto) guardando fuori (la volta stellata) e mostrava come procedere in questo cammino con il rigore proprio della geometria e dell’aritmetica che, tenute l’una insieme all’altra, costituivano l’inflessibile canone di verità. Nel segmento di retta così costituito – nel rapporto tra la rigorosa necessità fuori e dentro di sé – era possibile cogliere l’intersezione – altrimenti ineffabile – tra umano e divino. Intersezione comune a uomini e donne appartenenti a credo, popoli, culture diverse, ma che esclude qualsiasi forma di potere che pretenda di imporre alla mente e ai corpi degli esseri umani un cammino inconciliabile con quello indicato da questo canone di verità che non si piega».
Stiamo, allora, dalla parte di Ipazia. Stiamo dalla parte del canone di verità, stiamo dalla parte della Tradizione. Consapevoli che in questa età del ferro, il nostro kali-yuga, un tempo oscuro ma certo non eterno, il martirio dell’iniziato o dell’iniziata più che cruento è una pena sottile e dissimulata. Il patimento che si soffre ha una forma raffinata, ardua da vedere e che difficilmente si manifesta, perché non culmina nello spargimento di sangue ma deve verificarsi lentamente, quotidianamente, senza sangue o sofferenza fisica, in un patire continuo che è un agire contro ogni forma di intolleranza. Ma anche, occorre sottolinearlo, deve essere uno spogliarsi dello stereotipo della tolleranza. È questo, infatti, un termine ignoto agli Antichi che non erano tolleranti, perché, non essendo intolleranti, non ne avevano bisogno. La tolleranza, in questa sua modernità, tiene insieme un valore tendenzialmente positivo e un pericolo di tipo etimologico. Volenti o nolenti, abbiamo assorbito dalla dimensione cristiana, nella quale ci troviamo immersi da tempo, questo concetto, dal quale neanche un Libero Muratore è libero, checché possa pensarlo. Sono sicuro che molti di noi ben comprendano che la tolleranza, spesso concepita come punto di avvio di un dialogo fra diversi, contrassegni, contemporaneamente, una sorta di graduatoria fra i diversi stessi: il rispetto che si sottintende nel termine cela, infatti, la sofferenza, la pazienza, la sopportazione, l’accettazione, che si risolve in una forma di superiore carità, non dissimile da quella che hanno le religioni monoteiste verso chi è in errore e pecca. Quando ci saremo liberati da questa incrostazione (che prude come una pustola cronica), allora avremo raggiunto la capacità di pensare in modo plurale ciò che ci circonda, di amarlo e rispettarlo, di essere aperti e flessibili, perché nell’En To Pan, l’Uno il Tutto, siamo tutti stelle e astri dello stesso infinito firmamento. E questa sarà la buona novella del ciclo futuro. Quello in cui si potrà dire: Eccoti, Ipazia, risorta tra noi.
Moreno Neri
